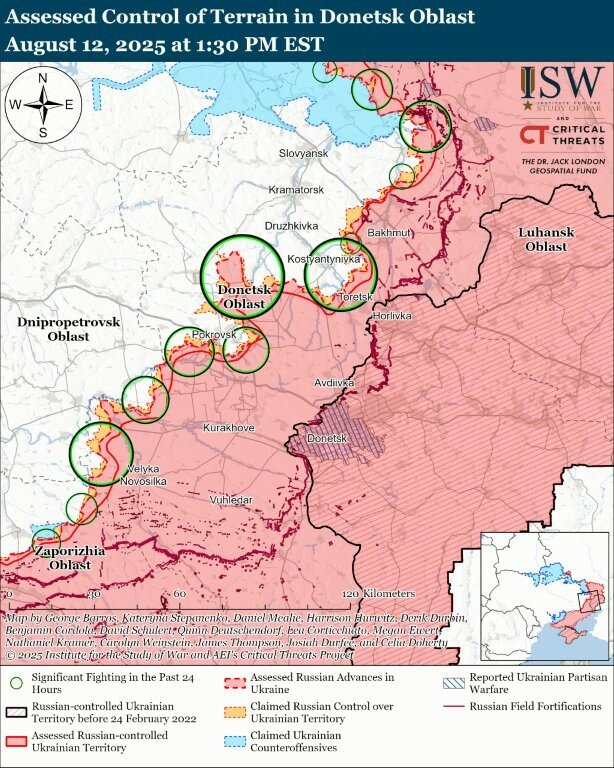"Quando hanno deciso che ci collocavamo nel "campo largo"? Quando hanno deciso di no? Quando ci hanno definiti "progressisti liberi e popolari", ti hanno fatto partecipare? Quando hanno deciso di fare una costituente e di organizzarla con quelle modalità, sei stato coinvolto? Quando hanno organizzato i gruppi territoriali, hai dato il tuo parere? Sei stato coinvolto?
Chiamarsi ancora Movimento Cinque Stelle è un'offesa all'intelligenza delle persone e a un'intera comunità. Io provengo da un Movimento che costruiva le leggi insieme e che mi chiedeva se partecipare a un governo o no. Io ho memoria e ancora qualche neurone attivo".
Esprimiamo un sentimento di grande delusione, probabilmente condiviso da molti che hanno vissuto il Movimento 5 Stelle nella sua fase più partecipativa e collaborativa.
Il nostro messaggio mette in evidenza uno scollamento tra le scelte verticistiche “vissute” e la visione originaria di un movimento costruito dal basso, dove ogni decisione era frutto di discussioni collettive e di un processo decisionale inclusivo. Questo cambiamento è stato spesso criticato da chi, come noi, ricordano un'epoca in cui il Movimento incarnava i principi di democrazia diretta, coinvolgendo la base nelle decisioni fondamentali.
La riflessione sull’identità del Movimento 5 Stelle e sulla sua evoluzione negli anni è un tema centrale per chi si sente tradito nelle aspettative iniziali. Esprimere queste riflessioni apertamente può contribuire a stimolare un dibattito più ampio sulla necessità di recuperare uno spirito realmente partecipativo e trasparente, o, in alternativa, a interrogarsi su come tali ideali possano essere riproposti in un contesto politico diverso.
Pensiamo che la prima ipotesi sia oggi non più praticabile.
1. La crisi del modello partecipativo originale
Il Movimento 5 Stelle nasce come un esperimento innovativo di democrazia diretta, che voleva dare ai cittadini comuni il potere di influenzare le decisioni politiche, senza delegare tutto ai rappresentanti tradizionali. La piattaforma Rousseau, pur con tutti i suoi limiti, rappresentava l’idea di un coinvolgimento diretto degli iscritti. Negli anni, però, quel modello sembra essere stato tradito.
Le decisioni verticistiche: Alcune scelte fondamentali, come alleanze politiche e cambiamenti strategici, sono state prese senza un reale coinvolgimento della base. Ad esempio, il passaggio da un atteggiamento “né di destra né di sinistra” a una progressiva integrazione in un “campo largo” con il centrosinistra è stato spesso criticato per la mancanza di consultazione.
La scomparsa dei momenti di costruzione collettiva: All’inizio, le proposte di legge venivano costruite insieme agli attivisti, utilizzando strumenti online e assemblee territoriali. Questo aspetto partecipativo è stato progressivamente ridotto, lasciando spazio a una gestione più tradizionale e accentrata.
2. Il senso di tradimento per chi ha creduto in un movimento diverso
Molti attivisti e sostenitori sentono di essere stati esclusi dal processo decisionale. Questa situazione può derivare da:
La professionalizzazione della politica interna: Molti leader del Movimento hanno abbracciato logiche di realpolitik, giustificando decisioni con il bisogno di “responsabilità” o “governabilità”, allontanandosi dalla promessa originaria di rompere con il sistema.
La distanza dai territori: La perdita di centralità dei gruppi locali e delle assemblee territoriali ha fatto sentire molti esclusi e disillusi.
3. La metamorfosi identitaria
Quando il Movimento si definiva semplicemente come “Cinque Stelle”, le sue battaglie erano chiare: ambiente, acqua pubblica, trasporti sostenibili, connettività e sviluppo equo. Oggi, l’evoluzione verso definizioni più vaghe come “progressisti liberi e popolari” ha generato confusione:
Che cosa significa oggi essere M5S? La transizione verso una politica più tradizionale e meno radicale ha sollevato dubbi sulla coerenza con i principi fondanti.
Il problema del nome: Continuare a chiamarsi Movimento Cinque Stelle quando le sue dinamiche non rispecchiano più l’approccio originale appare contraddittorio e falso.
4. Riflessioni per il futuro
Se, come suggeriamo, c’è una comunità delusa ma ancora attiva e pronta a contribuire, è legittimo chiedersi quali strade possano essere percorse:
Riformare il Movimento dall’interno: Questo richiederebbe una vera autocritica e una riapertura degli spazi partecipativi, ricostruendo fiducia tra la base e i vertici.
Creare un nuovo progetto: Alcuni ex attivisti hanno già intrapreso questa strada, fondando nuove realtà politiche o movimenti civici locali che riprendono lo spirito originario.
Stimolare un dibattito pubblico: Rendere evidente la distanza tra il Movimento attuale e i suoi principi fondativi potrebbe spingere a una riflessione collettiva sull’importanza della coerenza politica.
5. Il valore della memoria e dell’identità politica
Le nostre parole, che rivendicano la memoria del Movimento e la partecipazione attiva, toccano un punto fondamentale: la politica è fatta di idee e identità, ma anche di coerenza e fiducia. Chi, come noi, ricorda una fase più autentica e coinvolgente, rappresenta una risorsa preziosa per qualsiasi iniziativa futura che voglia rifarsi a quei valori.
Creare nuovi spazi partecipativi richiede un approccio metodico e ispirato a principi di inclusività, trasparenza e autonomia.
Vi proponiamo alcune strategie pratiche articolate in fasi operative:
1. Coinvolgimento attivo della comunità
a. Mappare le risorse e le esigenze locali
Organizzare incontri aperti nei territori per identificare bisogni, idee e persone disposte a contribuire.
Usare strumenti digitali (sondaggi online, piattaforme collaborative) e metodi tradizionali (assemblee pubbliche, questionari) per raccogliere opinioni.
b. Costruire una rete di base
Identificare referenti locali o "facilitatori" che possano coordinare le attività sul territorio.
Sfruttare i social network e le app di messaggistica per creare gruppi locali dedicati al confronto costante.
2. Creazione di strutture organizzative trasparenti
a. Definire regole condivise
Redigire un regolamento partecipativo semplice e chiaro, che stabilisca come vengono prese le decisioni (voti, consenso, assemblee).
Prevedere una rotazione delle cariche per evitare accentramenti di potere.
b. Piattaforme per la democrazia diretta
Usa strumenti open-source come Decidim, Loomio, o LiquidFeedback per consentire la partecipazione digitale.
Consentire ai membri di proporre e votare idee, con soglie di supporto per trasformarle in progetti concreti.
3. Progettazione di attività partecipative
a. Laboratori di co-creazione
Organizzare workshop tematici (ad esempio, sull’ambiente, la mobilità, o i diritti sociali) dove i partecipanti lavorano in piccoli gruppi su proposte concrete.
Utilizzare tecniche come il World Café o l’Open Space Technology per favorire scambi aperti e creativi.
b. Assemblee deliberative
Sviluppare un calendario di assemblee periodiche (mensili o trimestrali) per aggiornamenti, discussioni e decisioni.
Alternare incontri online e fisici per facilitare la partecipazione anche a chi è geograficamente distante.
c. Eventi pubblici e campagne educative
Organizzare incontri pubblici con esperti, giornalisti o accademici per educare la comunità su temi di interesse.
Realizzare attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri.
4. Comunicazione trasparente e inclusiva
a. Creare strumenti di comunicazione chiari
Pubblicare regolarmente resoconti delle attività e delle decisioni prese, accessibili a tutti.
Utilizzare un linguaggio semplice e inclusivo per evitare che il tecnicismo escluda chi non ha esperienza politica.
b. Valorizzare i contributi individuali
Riconoscere pubblicamente l’impegno dei membri attivi, per incentivare altri a partecipare.
Usare formati collaborativi, come le "storie partecipate", per raccontare i successi.
5. Implementazione di progetti locali concreti
a. Partire da obiettivi realizzabili
Identifica progetti concreti a breve termine (come la gestione di un orto urbano, una campagna di pulizia, o eventi culturali comprendendo volantinaggi a tema e petizioni) e a lungo termine che includa esperienze su percorsi culturali e monumentali, includendo soggetti immateriali per dimostrare l’efficacia dell’azione collettiva.
b. Rendere i risultati visibili
Documenta e comunica ogni successo: le persone sono più inclini a partecipare quando vedono che i loro sforzi producono effetti tangibili.
6. Sostenibilità e crescita del progetto
a. Formare i membri attivi
Organizza corsi di formazione su temi come la progettazione partecipativa, la comunicazione politica o l’organizzazione comunitaria.
b. Diversificare le fonti di finanziamento
Usa il crowdfunding per finanziare i progetti, ma cerca anche partnership con associazioni, enti locali o imprese etiche.
c. Valutare periodicamente il processo
Introduci momenti di revisione collettiva per analizzare cosa sta funzionando e cosa va migliorato.
Esempi pratici di successo
a. Il modello di Barcellona en Comú
Movimento politico locale a Barcellona nato per coinvolgere i cittadini nelle decisioni amministrative. Hanno usato piattaforme digitali e assemblee popolari per scrivere un programma partecipativo.
b. Bilanci partecipativi
In molte città del mondo, i cittadini decidono direttamente come utilizzare parte del bilancio comunale. Questa pratica aumenta la fiducia nella politica locale.
c. Community Land Trusts
Esperienze in cui le comunità si uniscono per gestire spazi pubblici, case o terreni, garantendo un uso equo e sostenibile delle risorse.
Il bilancio partecipativo
Ora approfondiamo un modello specifico e adattabile: il bilancio partecipativo. È uno strumento molto efficace per coinvolgere direttamente le persone nella gestione delle risorse, ed è adattabile a diversi contesti: quartieri, città, associazioni o movimenti.
Cosa è il bilancio partecipativo?
Il bilancio partecipativo è un processo attraverso il quale una comunità decide come allocare parte del budget disponibile per progetti e iniziative.
Nasce come strumento di democrazia diretta ed è stato sperimentato con successo in città come Porto Alegre (Brasile) e Barcellona (Spagna).
L'obiettivo è creare un dialogo tra cittadini e amministratori, incentivare la trasparenza e favorire l'empowerment delle comunità locali.
Come funziona in pratica?
1. Definizione delle regole
Prima di iniziare, è necessario stabilire alcune regole fondamentali:
Quale parte del budget sarà gestita dalla comunità? Ad esempio, il 5-10% delle risorse di un’organizzazione, di un bilancio comunale o di un fondo di associazione.
Quali sono le priorità? Si può scegliere di concentrarsi su temi specifici (es. ambiente, mobilità, cultura) o lasciare carta bianca.
2. Coinvolgimento della comunità
Fase informativa: Comunicare il progetto a tutte le parti interessate tramite incontri pubblici, volantini, social media, e-mail e reti locali.
Creazione di spazi di dialogo: Organizza assemblee aperte o gruppi di lavoro per raccogliere proposte dai partecipanti.
3. Raccolta delle proposte
I membri della comunità possono proporre progetti o idee:
Progetti concreti, come ristrutturare un parco, organizzare eventi culturali o creare infrastrutture per il quartiere.
Azioni strategiche, come promuovere una campagna educativa o finanziare progetti di formazione.
Strumenti utili:
Incontri fisici: Favoriscono il confronto diretto.
Piattaforme digitali: Siti web o app dedicate dove i cittadini possono inviare e discutere proposte.
4. Valutazione delle proposte
Un gruppo tecnico o un comitato misto (composto da cittadini e amministratori) verifica la fattibilità delle proposte:
Disponibilità economica.
Tempi di realizzazione.
Rispetto delle normative.
5. Votazione
Le proposte vengono sottoposte a voto:
Fisico: Durante assemblee, con urne o schede.
Online: Attraverso piattaforme digitali sicure e che utilizzano ingressi con SPID o simili.
Ogni membro della comunità può esprimere le sue preferenze per scegliere i progetti da finanziare.
6. Realizzazione e monitoraggio
I progetti più votati vengono finanziati e realizzati.
I cittadini monitorano lo stato di avanzamento attraverso aggiornamenti periodici, incontri o report online.
Adattamento al tuo contesto
Per adattare il bilancio partecipativo alla nostra realtà:
Identificare un ambito di applicazione: Può essere un quartiere, un gruppo di attivisti o un’associazione con risorse comuni.
Partire con una scala ridotta: Ad esempio, utilizza un budget simbolico o risorse non monetarie (es. volontariato o beni condivisi).
Utilizzare strumenti a basso costo:
Per le piattaforme digitali, sfrutta software open-source come Decidim o Loomio.
Per i voti fisici, usare soluzioni semplici come urne nei centri di ritrovo locali.
Vantaggi del bilancio partecipativo
Inclusività: Coinvolge persone che spesso non partecipano alla politica attiva.
Trasparenza: Rende chiaro come vengono utilizzate le risorse.
Fiducia: Rafforza il legame tra le persone e le istituzioni o i gruppi organizzatori.
Risultati tangibili: La comunità vede realizzati i progetti che ha scelto.
Un esempio pratico per iniziare (Casale Apollosa)
Supponiamo che si stia lavorando con un gruppo locale per migliorare il quartiere. Ecco come potrebbe funzionare:
Definisci il budget: Ad esempio, 35.000 euro per beni acquistabili a basso costo e ristrutturarli e migliorare gli spazi comuni.
Raccoglire le proposte: Durante un incontro, le persone propongono idee come:
Contribuire nella fase di riattivazione del bene.
Organizzare un festival culturale.
Creare una biblioteca condivisa.
Votare le proposte: Ogni partecipante vota online o durante un evento.
Realizzare i progetti più votati: Comunica i progressi e organizza un evento per celebrare i risultati.
Creare una piattaforma digitale per il bilancio partecipativo
Una piattaforma digitale può facilitare ogni fase del processo partecipativo, rendendolo più accessibile, trasparente e tracciabile.
Ecco i passaggi per realizzarla e integrarla nel progetto.
1. Scelta della piattaforma
Puoi scegliere tra piattaforme già esistenti o personalizzate, in base alle risorse e alle competenze tecniche disponibili.
Piattaforme Open-Source già pronte
Decidim
Creato per la democrazia partecipativa, permette di raccogliere proposte, discutere e votare.
Offre strumenti per monitorare le decisioni e valutare i progressi.
Ideale per comunità con molte proposte e alta partecipazione.
Loomio
Semplice e collaborativa, adatta a discussioni e decisioni rapide.
Perfetta per piccoli gruppi o fasi iniziali di un progetto.
Consul
Usato da molte città europee per il bilancio partecipativo.
Consente discussioni, votazioni e monitoraggio delle decisioni.
YourPriorities
Molto intuitiva, consente di raccogliere idee e voti in modo semplice.
Costruzione di una piattaforma personalizzata
Utilizzazione di domini personalizzati con piattaforme economiche come “Fazio”.
Vantaggi: Puoi adattare la piattaforma ai bisogni specifici (design, flussi, lingue).
Costi e tempi: Richiede un budget limitato e un tempo per lo sviluppo non esagerato.
2. Funzionalità fondamentali
Registrazione e autenticazione
Consentire l'accesso solo ai membri della comunità (es. residenti di un'area).
Usa metodi sicuri di verifica, come:
Email con link di conferma.
Documenti o codici generati localmente.
Raccolta delle proposte
Crea moduli intuitivi per descrivere i progetti:
Titolo e descrizione.
Obiettivi e benefici attesi.
Stima dei costi e risorse necessarie.
Discussione e feedback
Aggiungi una sezione per commenti o votazioni preliminari sulle idee.
Usa un sistema di like/dislike o voti di priorità per identificare proposte popolari.
Votazione
Opzioni di voto personalizzabili:
Voto singolo: Ogni utente sceglie una proposta.
Voto multiplo ponderato: Ogni utente distribuisce un numero di punti (es. 10) tra varie proposte.
Sistema di approvazione: Ogni utente vota “sì” o “no” per ogni proposta.
Trasparenza e monitoraggio
Una dashboard per visualizzare:
Proposte più votate.
Stato di avanzamento dei progetti.
Aggiornamenti automatici sullo stato dei lavori.
3. Metodo di votazione più adatto
La scelta del metodo di voto dipende dal contesto e dagli obiettivi.
a. Voto singolo semplice
Quando usarlo:
Comunità piccole o decisioni semplici.
Adatto se vuoi identificare chiaramente un progetto prioritario.
Pro: Facile da gestire e capire.
Contro: Non permette di esprimere più preferenze.
b. Voto ponderato (metodo preferenziale)
Ogni partecipante distribuisce un numero di punti (es. 10) tra più proposte.
Quando usarlo:
Comunità con molte proposte.
Quando vuoi capire l'intensità delle preferenze.
Pro: Permette ai cittadini di indicare più priorità.
Contro: Può essere meno intuitivo per alcune persone.
c. Metodo di approvazione
Ogni proposta viene votata con “sì” o “no”. Le proposte con la percentuale più alta di “sì” vengono selezionate.
Quando usarlo:
Decisioni legate a un budget condiviso.
Quando vuoi garantire il consenso generale.
Pro: Stimola una maggiore inclusività.
Contro: Non permette di distinguere le preferenze tra progetti approvati.
4. Implementazione pratica
Promuovere il processo: Informa la comunità su come registrarsi e partecipare tramite canali digitali, volantini o eventi pubblici.
Testare la piattaforma: Prima del lancio, organizzare una fase di test con un gruppo ristretto di utenti.
Formazione e supporto: Fornire tutorial o sessioni di formazione per aiutare le persone a utilizzare la piattaforma.
5. Budget e risorse
Piattaforme open-source: Spesso gratuite, ma si potrebbero avere costi di hosting e personalizzazione (circa 500-2000 euro).
Piattaforme personalizzate: Costi variabili, da 100,00 euro in su, a seconda delle funzionalità richieste.
Crowdfunding: Raccogliere fondi per finanziare la piattaforma e coinvolgere direttamente la comunità. (Fonti A.I.)